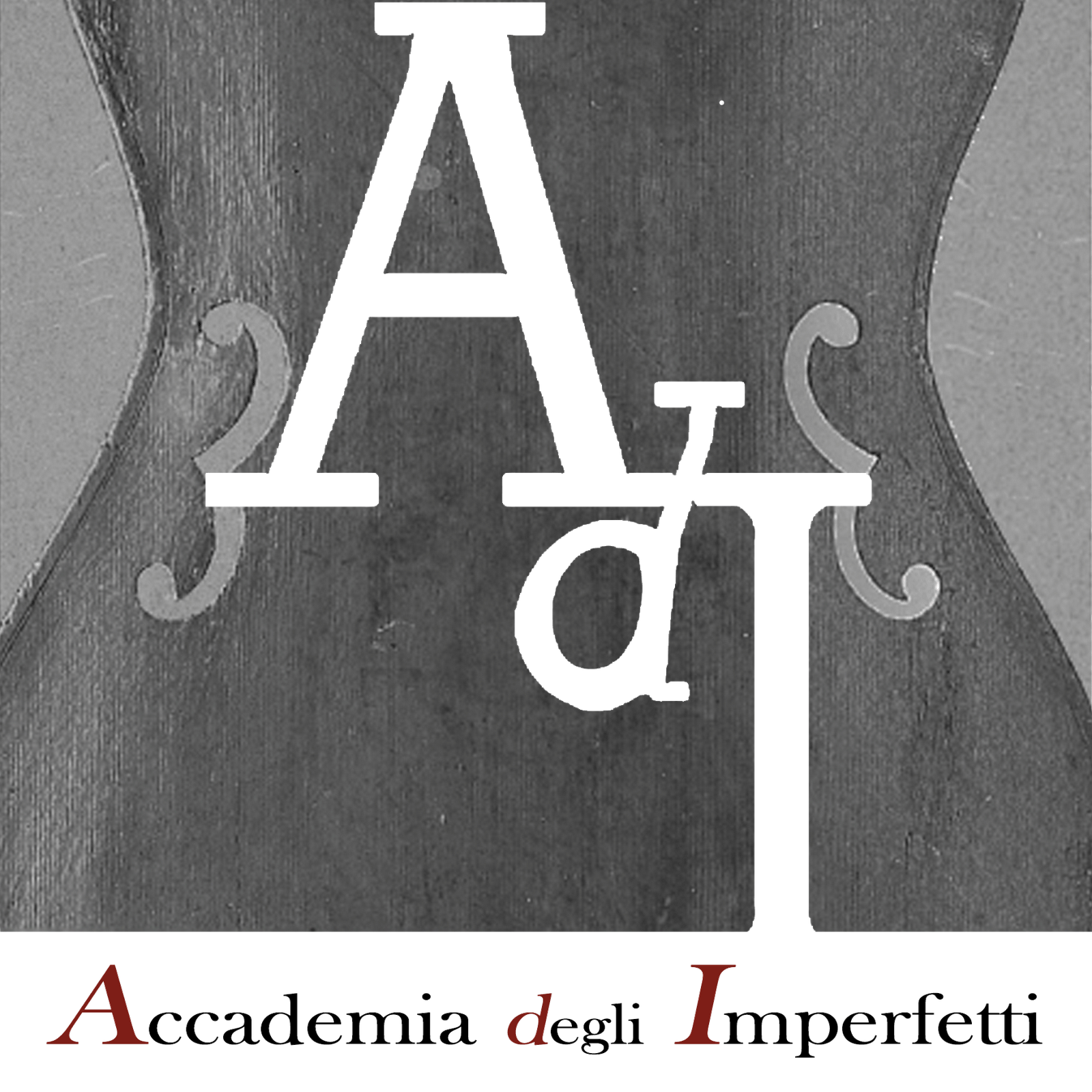
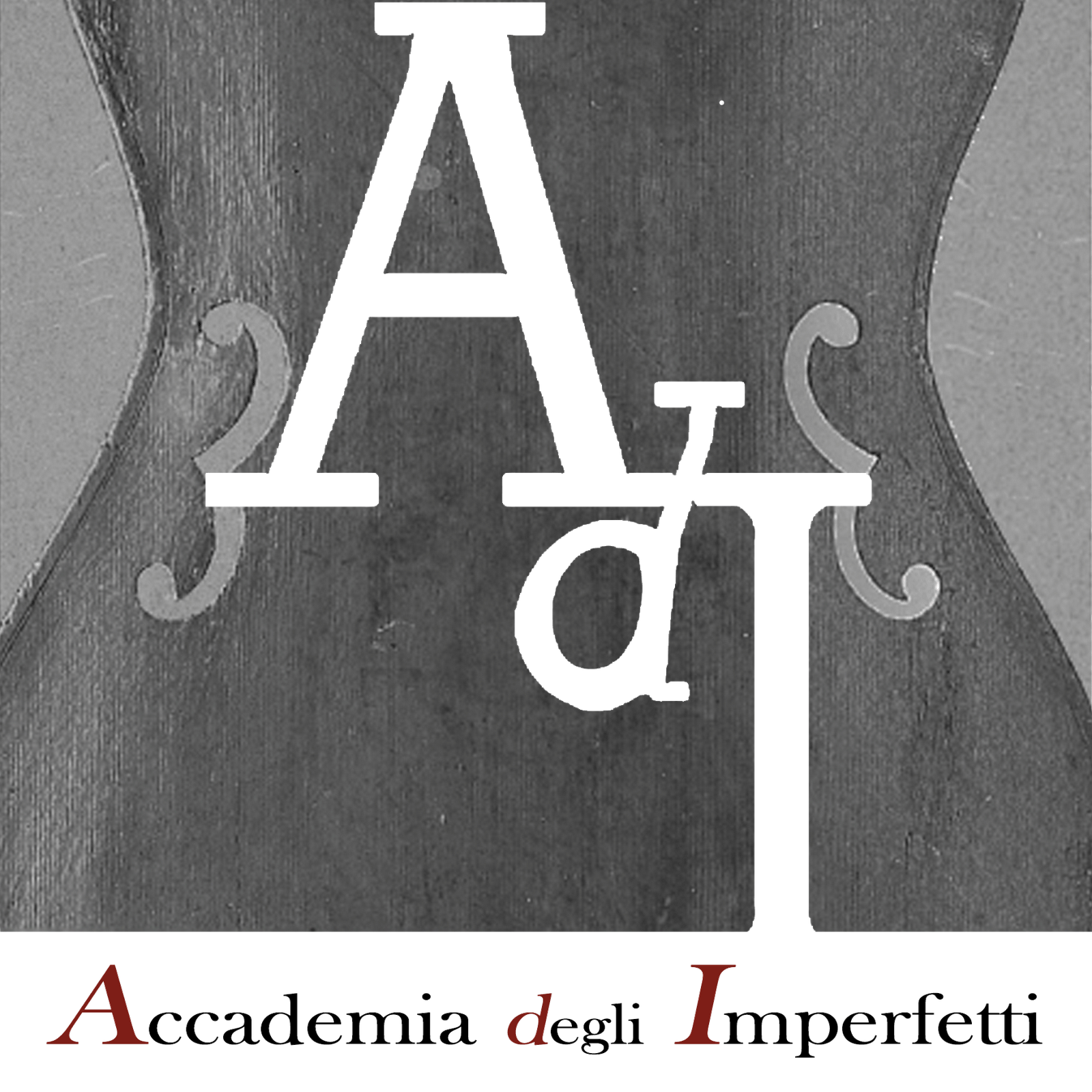
Pasión y Melancolía
dal Cancionero del Duca di Calabria, o di Uppsala
PRESENTAZIONE
Si veda, per alcune informazioni generali, la presentazione del primo CD della raccolta, Humanos y Divinos.
Riportiamo qui di seguito la presentazione proposta dalla Casa Editrice.
Questo album di Da Vinci Classics costituisce il secondo volume di
una pubblicazione dedicata a quello che oggi è noto come il Cancionero de Upsala (sic), ma che è anche designato con diversi
altri nomi, ognuno dei quali racconta una parte della sua storia.
In primo luogo,
Upsala sembra ora un errore di stampa, ma era il nome corretto della
città di Uppsala all'inizio del XX secolo, prima della grande
riforma ortografica della lingua svedese. Fu a Upsala, o Uppsala, che
un musicologo spagnolo, Rafael Mitjana, trovò una raccolta su cui
apparentemente nessuno aveva scritto nulla nella letteratura
accademica. Mitjana la studiò e la discusse approfonditamente,
legando così il suo nome a quello della raccolta; gradualmente, col crescente sviluppo degli studi musicologici, divenne evidente
che il volume di Uppsala è probabilmente l'unica copia sopravvissuta
di questo libro di Scotto, uno dei
principali editori e tipografi di musica del XVI secolo. La stampa
musicale era ancora un'attività molto recente, sebbene alcuni
tipografi musicali, come Ottaviano Petrucci, avessero raggiunto
risultati di eccellente qualità e di impressionante bellezza molto
presto. Scotto aveva sede a Venezia, una delle città più vivaci del
mondo all'epoca; una città in cui cultura, marketing, arte e
relazioni internazionali erano fiorenti. Da Venezia, oggetti di ogni
genere potevano viaggiare in tutto il mondo, e non era affatto
impossibile che la musica stampata lì potesse infine approdare in
Svezia. Dalla provenienza del libro deriva quindi un altro dei suoi
nomi, ovvero Cancionero de Venecia. Può sorprendere, tuttavia, che –
dato l'elevato numero di libri di canzonieri stampati a Venezia nella
seconda metà del XVI secolo – il nome Cancionero de Venecia
potesse essere attribuito inequivocabilmente a una particolare
pubblicazione. Il punto è che, sì, è vero che a Venezia furono
pubblicati moltissimi libri di musica, ma non molti di questi erano
canzoni con testi in spagnolo. In effetti, per quanto riguarda la
tipografia Scotto, questo libro sembra essere stato l'unico con testi
in spagnolo. Pertanto, se "Canzoniere di Venezia" sarebbe
un'indicazione troppo generica (dato che esistevano molti libri di
canzoni in italiano), "Cancionero de Venecia" è un nome
unico.
Un'ulteriore
specificazione geografica è contenuta in un altro dei tanti nomi del
libro, ovvero Cancionero del Duque de Calabria, il libro
di canzoni del Duca di Calabria. Chi era questo Duca di una regione
dell'Italia meridionale, la regione più vicina alla Sicilia? In
realtà era uno spagnolo; ovvero il Duca Ferdinando d'Aragona
(1488-1550), viceré e luogotenente generale del Regno di Valencia. E
questo ci porta a un altro luogo, la città spagnola di Valencia, che
è in realtà quella più rilevante per il libro in esame. Valencia,
a quel tempo, era stata per quasi un secolo una delle città più
brillanti e vivaci dell'Europa meridionale, a scapito di altre
regioni iberiche come Castiglia e Catalogna. La città divenne un
punto d'incontro, un crocevia e un crogiolo di influenze e persone
provenienti dalle più diverse zone d'Europa; Sotto il dominio del
"Duca di Calabria", acquisì anche un prestigio
internazionale dal punto di vista musicale. Ferdinando, erede del
Regno di Napoli (da cui il titolo di "Duca di Calabria"),
ricevette un'educazione degna di un principe del Rinascimento
italiano, assorbendo una cultura che finalmente poté tradurre in
azioni concrete a Valencia.
La vita di
Ferdinando fu molto avventurosa e pittoresca, tra esilio, prigionia,
libertà concessa dall'imperatore Carlo I e due matrimoni: dopo
essere rimasto vedovo, si risposò con la Marchesa di Cenete, donna
colta e seguace di Erasmo da Rotterdam. Assumendo il Vicereame di
Valencia, fece in modo che l'intera biblioteca della madre venisse
trasferita da Ferrara, dove aveva risieduto.
In un simile
contesto, Ferdinando desiderava fare della sua corte un rifugio per
letterati, artisti, pensatori e simili. Era un vero uomo del
Rinascimento, con una curiosità insaziabile e molteplici interessi
culturali. Come affermò un osservatore contemporaneo, all'epoca in
Spagna non esisteva una cappella musicale paragonabile a quella di
Ferdinando, in termini di qualità delle voci, strumentisti e valore
artistico. Ispirato dalle cappelle italiane, Ferdinando iniziò a
costruire la propria cappella musicale, che divenne rapidamente la
più importante della Penisola Iberica.
Attraverso i suoi
vari nomi, abbiamo quindi già delineato un profilo del Cancionero.
Si tratta di una raccolta di cinquantaquattro villancicos, ovvero la
forma vocale tipica del Rinascimento spagnolo. I testi sono per lo
più profani, ma vi è una presenza non trascurabile di canti
natalizi (dodici). Sebbene i concetti di sacro e profano fossero
diversi nel XVI secolo rispetto a quelli odierni, i canti natalizi
erano considerati una via di mezzo. Potevano essere cantati in chiesa
durante le festività natalizie, periodo nel quale molte delle consuete
limitazioni al canto in volgare venivano eliminate; ma venivano
eseguite anche in contesti profani, insieme a canzoni d'amore. I
canti non sono attribuiti nella stampa, ma la loro paternità è
stata attribuita a musicisti che erano in stretto contatto con la
corte aragonese, ad esempio Pere Joan Aldomar, Bartolomeu Cárceres,
Mateo Flecha el Viejo (che potrebbe essere stato maestro di cappella)
e Cristobal de Morales.
L'unicità di questa
raccolta deriva innanzitutto dalla sua rarità. Come detto, questa
raccolta come tale sopravvive in questa unica copia; ma in generale
esistono pochissime raccolte di questo tipo risalenti alla Spagna del
XVI secolo. Tra queste, il Cancionero de Medinaceli e la Recopilación
de sonetos y villancicos (1560) di Juan Vázquez. In origine,
nonostante i molti nomi con cui viene attualmente indicato, il libro
recava la seguente iscrizione: "Villancicos de diversos Autores,
a dos, y a tres, y a quatro, y a cinco bozes, agora nuevamente
corregidos. Ay mas ocho tonos de Canto llano, y ocho tonos de Canto
de Organo para que puedan aprovechar los que A cantar començaren.
Venetiis, Apud Hieronymum Scotum, MDLVI”. Questo si traduce
come "Villancicos di diversi compositori, in due, tre, quattro e
cinque parti, nuovamente corretti. Vi sono inoltre otto toni di canto
piano e otto organa di cui trarranno profitto coloro che cominciano a
cantare. A Venezia, da Girolamo Scotto, 1556".
Come recita il
titolo, una caratteristica molto speciale della raccolta è la
presenza di otto brani a una voce e otto a due voci: i primi
strutturati in modo simile al canto piano, negli otto modi
ecclesiastici, e i secondi come bicinia, ovvero semplici contrappunti
a due voci che consentono un approccio progressivo al canto
polifonico. Come li definisce un critico, questi ultimi sono
"fantasie imitative effettivamente a due voci, costruite su una
varietà di temi e dispositivi contrappuntistici che possono essere
utilizzati proficuamente per il canto o l'esecuzione strumentale",
nel tipico approccio "adattivo" che caratterizza la
transizione dal canto all'esecuzione nel tardo Rinascimento. Questo
secondo CD del progetto dedicato al Cancionero comprende infatti un
totale di sedici brani vocali e cinque opere strumentali, alcune
delle quali vengono presentate qui in prima mondiale. Nonostante il
Cancionero sia conosciuto e studiato da circa 120 anni, alcune delle
sue componenti sono state praticamente trascurate sia dagli studiosi
sia dagli esecutori fino a tempi recenti. Un importante impulso verso
una maggiore conoscenza degli elementi "marginali" del
Cancionero è giunto con la pubblicazione, nel 2003, di una nuova
edizione facsimile accademica del libro; tuttavia, ciò non è stato
sufficiente a gettare piena luce sull'opera nella sua interezza e ad
apprezzarne appieno il potenziale in termini artistici, accademici e
musicali.
Inoltre, il
Cancionero non è apparso nel vuoto; pertanto, con grande perspicacia
e utilità, questa registrazione lo inquadra nel suo contesto,
aggiungendovi altri tre brani per soli strumenti, riconducibili
all'esperienza musicale vissuta alla corte di Valencia.
Il leitmotiv e il
filo conduttore adottato dagli esecutori nella selezione e
nell'ordinamento dei brani è la giustapposizione dei due volti
dell'amore. Soprattutto nel Rinascimento (e soprattutto grazie al
movimento noto come Petrarchismo), la commistione di delizia e
dolore, piacere e desiderio, passione e malinconia nell'esperienza
amorosa era profondamente sentita, e parolieri e poeti giocarono
abbondantemente su questo topos. In definitiva, questa polarità può
essere interpretata come l'eterno duello tra eros e Thanatos, amore e
morte. Nonostante queste auguste radici letterarie, il tono dei testi
cantati nel Cancionero non è eccessivamente elevato. La presenza di
questi temi e soggetti in una poesia a tratti popolare e colloquiale
testimonia la pervasività di questo approccio e la sua migrazione
dalla letteratura "alta" alla vita quotidiana. Le
caratteristiche musicali sono quelle tipiche dei villancicos su temi
inerenti all'amore. Due dei brani della raccolta, ovvero No soy yo
quien veis bivir e Dime robadora, sono proposti sia in forma a due
che a tre voci; quest'ultima versione è ottenuta aggiungendo una
parte grave alle due voci superiori preesistenti. Grazie a questa
soluzione, due nuovi brani prendono vita, quasi come se si trattasse
di un gioco musicale derivato dall'intrattenimento di corte, in un
nuovo tipo di virtuosismo compositivo. Gli esecutori di questo CD
hanno scelto di unificare le due versioni di ciascun brano, eseguendo
la realizzazione a due voci come prima sezione di un brano composito,
la cui seconda metà è costituita dalla versione a tre voci.
Per quanto riguarda
i brani strumentali del Cancionero, vengono eseguiti quattro degli
otto bicinia o organa (duetti concepiti pedagogicamente) e uno degli
otto canti gregoriani. L'intento didattico è evidente in entrambi i
casi, sebbene riguardi rispettivamente l'esecuzione e la
composizione.
La realizzazione e
lo sviluppo di un contrappunto sul Canto llano sono stati curati da
Giorgio Pacchioni, uno dei massimi esperti di contrappunto storico.
Si compone di quattro sezioni, in cui sono state suddivise ile 156
brevi dell'opera originale. A questa linea melodica vengono
aggiunte due parti superiori, in canone tra loro: ogni sezione ha
il proprio tempo, il proprio "ritardo" (canonico) e la
propria distanza intervallare tra le due voci.
L'applicazione di
tali espedienti e strategie compositive non solo consente
l'esecuzione e la registrazione di questa musica, ma è anche una
potente testimonianza della sua vivacità e fecondità. A distanza di
quasi cinque secoli, il materiale musicale raccolto nel Cancionero
continua a offrire sfide e nuove prospettive a compositori ed
esecutori, per la gioia degli ascoltatori di ieri, di oggi e di
domani. Chiara Bertoglio © 2024
PROGRAM NOTES
For some general information, see the presentation of the first CD of the collection, Humanos y Divinos.
Below we report the presentation proposed by Da Vinci Classics.
This
Da Vinci Classics album constitutes the second volume of a
publication dedicated to what is now known as the Cancionero de
Upsala (sic), but which is also designated through several other
names – each of which tells a part of its history.
Firstly,
Upsala now looks as a misprint, but it was the correct name of the
city of Uppsala at the beginning of the twentieth century, before a
great spelling reform of the Swedish language. It was in Upsala, or
Uppsala, that a Spanish musicologist, Rafael Mitjana, found a
collection about which nobody seemingly had written anything in
scholarly literature. Mitjana studied it and discussed it in depth,
thus binding his name to that of the collection; gradually, with the
increasing expansion of musicological studies, it became evident that
the Uppsala volume is probably the only surviving copy of this Scotto
book.
Scotto was one of the major publishers and printers of
music in the sixteenth century. Music printing was still a very
recent activity, even though some music printers, such as Ottaviano
Petrucci, had achieved results of excellent quality and impressive
beauty very soon.
Scotto was based in Venice, one of the
liveliest cities in the world at that time; a city where culture,
marketing, art, and international relations were blooming. From
Venice, items of all kinds could travel worldwide, and it was not
impossible at all that music printed there could eventually land in
Sweden. From the book’s provenance comes therefore another of its
names, i.e. Cancionero de Venecia. It may come as a surprise,
however, that – given the high number of songbooks printed in
Venice in the second half of the sixteenth century – the name
Cancionero de Venecia could have been attributed unambiguously to a
particular publication. The point is that, yes, it is true that a
great many music books were published in Venice, but not many of them
were songs with lyrics in Spanish. In fact, as concerns the Scotto
press, this book seems to have been the only one with Spanish texts.
Thus, if Canzoniere di Venezia would be too generic an indication
(since there were many songbooks in Italian), Cancionero de Venecia
is a unique name.
A further geographic specification is
contained in still another of the book’s many names, i.e.
Cancionero del Duque de Calabria, the Songbook of the Calabria Duke.
Who was this Duke of a region of Southern Italy – the region
closest to Sicily? It was a Spaniard, actually; i.e., Duke Ferdinand
of Aragon (1488-1550), the viceroy and lieutenant general of the
Kingdom of Valencia. And this brings us to yet another place, the
Spanish city of Valencia, which is the one actually most relevant to
the book under observation. Valencia, at that time, had been for
nearly a century one of the most brilliant and vibrant cities in
Southern Europe, at the expenses of other Iberian regions such as
Castille and Catalunya. he city became a meeting point, a crossroad,
and a melting pot of influences and people coming from the most
diverse zones of Europe; under the rule of the “Duke of Calabria,”
it also acquired an international standing from a musical viewpoint.
Ferdinand, the heir to the Kingdom of Naples (hence the title “Duke
of Calabria”), received an education befitting an Italian
Renaissance prince, absorbing a culture that he was finally able to
translate into concrete actions in Valencia.
Ferdinand’s life
had been very adventurous and picturesque, including exile,
imprisonment, freedom granted by Emperor Charles I, and two marriages
– after being widowed, he remarried the Marchioness of Cenete, a
cultivated woman and follower of Erasmus of Rotterdam. Upon assuming
the Viceroyalty of Valencia, he arranged for his mother’s entire
library to be brought from Ferrara, where she had resided.
Within
such an environment, Ferdinand was keen to establish his court as a
haven for literates, artists, thinkers, and the like. He was a true
Renaissance man, with unquenchable curiosity and manifold cultural
interests. As a contemporary observer stated, there was no musical
chapel in Spain at the time comparable to Ferdinand’s, in terms of
the quality of the voices, the instrumentalists, and their artistic
value. Inspired by Italian chapels, Ferdinand began building his own
musical chapel, which quickly became the foremost in the
Iberian Peninsula.
Through its various names, we have
therefore already sketched a profile of the Cancionero. It is a
collection of fifty-four villancicos, i.e. the vocal form typical for
the Spanish Renaissance. The lyrics are mostly secular, but there is
a non-negligible presence of Christmas carols (twelve). Although the
concepts of sacred and secular were different in the sixteenth
century in comparison with today’s, Christmas carols were
considered as somewhat in between. They could be sung in church
during the Christmas holidays, where many of the usual limitations to
vernacular singing were lifted; but they were also performed within
secular contexts, alongside love songs. The songs are unattributed in
the print, but their authorship has been ascribed to musicians who
were in close relationship with the Aragonese court – for instance
Pere Joan Aldomar, Bartolomeu Cárceres, Mateo Flecha el Viejo (who
may have been a chapel master), and Cristobal de Morales.
The
uniqueness of this collection derives first of all from its rarity.
As said, this collection as such survives in this single copy; but in
general there are very few such collections dating from
sixteenth-century Spain. Among them are the Cancionero de Medinaceli
and Juan Vázquez’s Recopilación de sonetos y villancicos
(1560).
Originally, in spite of the many names by which it is
currently indicated, the book bore the following inscription:
“Villancicos de diversos Autores, a dos, y a tres, y a quatro, y a
cinco bozes, agora nuevamente corregidos. Ay mas ocho tonos de Canto
llano, y ocho tonos de Canto de Organo para que puedan
aprovechar los que A cantar començaren. Venetiis, Apud Hieronymum
Scotum, MDLVI”. This translates as “Villancicos by several
composers, in two, three, four, and five parts, corrected again.
There are furthermore eight tones of plainchant and eight organa from
which those who begin to sing will profit. In Venice, at Jerome
Scotto’s, 1556”.
As the title reads, one very special
feature of the collection is the presence of the eight one-part and
eight two-part pieces – the former shaped in a fashion similar to
plainsong, in the eight Church modes, and the latter as bicinia, i.e.
simple two-part counterpoints allowing for a progressive approach to
polyphonic singing. As one critic defines them, these latter are
“effectively two-voiced imitative fantasies built on a variety of
themes and contrapuntal devices that can be used profitably for
singing or instrumental performance”, in the typical “adaptive”
approach characterizing the transition from singing to playing in the
late Renaissance.
This second CD of the project dedicated to the
Cancionero includes in fact a total of sixteen vocal pieces and five
instrumental works, some of which are presented here in world
premiere. In spite of the fact that the Cancionero has been known and
studied for approximately 120 years now, some of its components have
been virtually neglected by both scholars and performers until
recently. A major impulse toward a greater knowledge of the “fringe”
elements of the Cancionero came with the publication, in 2003, of a
new scholarly facsimile edition of the book; however, this has not
sufficed to shed complete light on the publication in its entirety
and to appreciate its full potential in artistic, academic, and
musical terms.
Furthermore, the Cancionero did not appear in a
void; therefore, very perceptively and usefully, this recording
frames it within its context, adding to the recording three more
pieces for instruments alone, which can be traced back to the musical
experience lived at the Court of Valencia.
The leitmotiv and the
red thread adopted by the performers in the selection and ordering of
the pieces is the juxtaposition of the two faces of love.
Particularly in the Renaissance (and especially thanks to the
movement known as Petrarchism), the mixture of delight and pain,
pleasure and desire, passion and melancholy in the experience of love
was deeply felt, and lyricists and poets played abundantly on this
topos. Ultimately, this polarity can be interpreted as the eternal
duel between eros and Thanatos, love and death. In spite of these
august literary roots, the tone of the lyrics sung in the Cancionero
is not excessively elevated. The presence of these themes and
subjects in a kind of poetry which is at times folklike and
colloquial bears witness to the pervasiveness of this approach, and
to how it migrated from “high” literature to daily life. The
musical features are those typical for the villancicos on subjects
inherent to love.
Two of the pieces in the collection, i.e. No
soy yo quien veis bivir and Dime robadora are offered both in two-
and in three-part settings; this latter version is obtained by adding
a lower part to the pre-existing upper two voices. Thanks to this
solution, two new pieces take life, almost as if playing a musical
game derived from court entertainment, in a new kind of compositional
virtuosity. The performers of this CD chose to unify the two versions
of each piece, performing the two-part realization as the first
section of a composite piece whose second half is made by the
three-part version.
As concerns the instrumental pieces of the
Cancionero, four out of the eight bicinia or organa
(pedagogically-conceived duos), and one of the eight plainchants are
performed here. The didactic intention is evident in both cases,
although it regards respectively performance and composition.
The
realization and development of a Counterpoint on the Canto llano has
been curated by Giorgio Pacchioni, who is one of the world’s
leading experts in historical counterpoint. It consists of four
sections, among which the original 156 breves of the original work
have been divided. Two upper parts, making a canon, are added to that
melodic line: each section has its own tempo, its (canonic) “delay”,
and its intervallic distance among the two voices.
The
application of such compositional devices and strategies is not only
what allows for the actual performance and recording of this music,
but also it is a powerful witness of its liveliness and fecundity. At
a distance of nearly five centuries, the musical material gathered in
the Cancionero continues to offer challenges and new perspectives to
composers and performers alike, for the delight of the listeners of
yesterday, of today, and of tomorrow. Chiara Bertoglio © 2024
TESTI
Ojos garços a la niña
Quien se los enamoraria
Son tan lindos y tan bivos
que a todos tienen cativos.
Y solo la vista dellos
me a Robado los sentidos
Y
los haze tan esquivos
que
Roban el alegria
Quien
se los enamoraria
TRADUZIONE ITALIANA
La
ragazza ha occhi azzurri, Chi (non) se ne
innamorerebbe?
Sono così belli e così vivi che
tengono tutti prigionieri.
E il solo vederli mi ha
rubato i sensi
E li ha tanto schivi che rubano
l’allegria:
Chi (non) se ne innamorerebbe?
Estas noches atan largas para
mi
No
solian ser ansi.
Solia
que reposava
las
noches con alegria
Y
el rrato que non dormia
Con
descanso lo passava
mas
estas que amor me grava
non
dormi
No
solian ser ansi
Queste notti così lunghe
per me
non solevano essere così.
Solevo
riposare le notti con gioia
e il tempo che non dormivo lo
passavo con ristoro.
Ma sono gravato dal peso dell'amore, non
ho dormito;
non solevano essere così.
Desdeñado soy de amor guardeos Dios de tal dolor
Desdeñado y malquerido.
Maltratado y aborreçido.
Y del tiempo que os he servido
no me dais ningun favor
No tengo ningun favor
guardeos Dios de tal dolor
Sono
disprezzato in amore, Dio ti risparmi tale
dolore!
Disprezzato e negletto, maltrattato ed
aborrito.
E per il tempo che ti ho servito non mi
dai nessun vantaggio,
non ricevo alcun favore:
Dio ti risparmi tale dolore!
No me las amuestras mas que
me mataras.
Son
tan lindas y tan bellas
que
a todos matas con ellas.
Y
aunque muero yo por ellas
No
me las amuestras mas
que
me mataras.
Non mostrarmele più che mi ucciderai.
Sono così
carine e così belle che con esse uccidi tutti.
E
anche se io muoio per loro
Non mostrarmele più che mi
ucciderai.
Si nos huviera mirado no
penara
Pero
tan poco hos mirara.
Veros
harto mal a sido
mas
no veros peor fuera.
No
quedara tan perdido
pero
mucho mas perdiera.
Que
viera aquel que nos viera
qual
quedara
Pero
tan poco hos mirara.
Se non ti avessi guardato
non soffrirei,
ma nemmeno ti guarderei.
Vederti è stato molto doloroso
ma non vederti sarebbe peggio.
Non resterei così perduto
ma perderei molto di più.
Cosa vedrebbe chi non ti ha visto?
Come resterebbe?
ma nemmeno ti guarderei.
Yendome y viniendo me
fuy Enamorando
Una
vez riendo
y
otra vez llorando.
Yo
estava sin veros
de
amor Descuydado.
Mas
en conoçeros
me
vi enamorado.
Nunca
mi cuidado
se
va moderando
aunqueste
riendo
y
otra vez llorando.
Senti
gran tormento
De
verme perdido
Mas
estoy contento
Pues
por vos a sido
El
mal es creçido
Y
a de yrse passando
[Una
vez riendoy
otra vez llorando.]
Otro
mayor mal
me
tiene ya muerto.
Es
tal que por cierto
no
tiene su ygual
Tieneme
ya tal
que
ya me va acabando
[Una
vez riendoy
otra vez llorando.]
Andando
e tornando Mi sono innamorato
Una volta ridendo un’altra
piangendo
Senza vederti ero indifferente
all’amore
ma nel conoscerti Mi sono visto
innamorato.
Mai la mia attenzione si va
attenuando
anche se stai ridendo oppure piangendo
Provai grande tormento
di vedermi perso
Ma sono contento perché
è stato per voi
Il male è cresciuto E
deve andarsene
passando
Una
volta ridendo un’altra piangendo
Un altro male più grande mi avrebbe già ucciso
è
tale che certamente non ha eguale
mi tiene già talmente che già mi sta finendo
Una volta ridendo un’altra piangendo
No soy yo quien veis bivir
No soy yo no no no Sombra soy de quien murio
Señora ya no soy yo
quien gozava vuestra
gloria.
Ya es perdida mi
memoria
quen el otro mundo
esta.
El que fue vuestro y
sera no so yo
No so yo no no no
Sombra soy de quien
murio.
Non
sono io quello che vedi vivere
Non io no no no io
sono l'ombra di quello che è morto.
Signora, non sono più io quello che ha goduto della tua gloria.
La mia memoria è già
persa che è già nell'altro mondo.
Quello che era tuo
e lo sarà non sono io
Non io no no no io
sono l'ombra di quello che è morto.
Andaran siempre mis osos
por
la gloria en que se vieron
llorando
pues la perdieron
Loraran
en contemplar
que
el tiempo
que
la gozavan
quando
de plazer lloravan
tanto
lloran De pesar.
Sea
tanto su llorar
por
el bien en que se vieron
que
çieguen pues la perdieron.
I
miei occhi andranno sempre piangendo
per la gloria in cui si
sono visti perché l'hanno persa.
Piangeranno vedendo
che il tempo
che la inorgoglivano
quando piangevano di piacere
tanto piangono di rammarico
Tanto sarà il loro pianto
per il bene in cui si vedranno
che si accecheranno per la perdita.
Alça la niña los oyos No para todos
Alçalos por Iubileo
por matarnos de desseo.
que la fiesta segun veo
no es para todos
La
ragazza alza gli occhi Non per tutti
Li alza per
Giubileo per ucciderci di desiderio.
che la festa,
come vedo, non è per tutti
No tienen vado mis males
que
hare
que
passar no los podre.
Es
impossible passallos
Males
que no tienen medio.
pues
para tener Remedio
el
Remedio es no curallos.
Mi
descanso es desseallos
porque
se
que
passar no los podre.
I miei mali non hanno via d’uscita: che farò, che
vincerli non potrò?
È impossibile vincerli, mali
che non hanno cura.
Perché per avere un rimedio il rimedio
non è curarli.
La mia tregua è accettarli perché
so che non potrò vincerli.
Dime Robadora que te mereçi
que ganas agora que
muera por ti
Yo siempre sirviendo
tu siempre
olvidando.
Yo siempre muriendo
tu siempre matando.
Yo soy quien tadoro
y tu contra mi
que ganas agora que
muera por ti.
Dimmi
Robadora, cosa ti meriti? Che vuoi ora? che muoia per te?
io
sempre a servire tu sempre a dimenticare
io muoio
morendo tu sempre uccidendo
Io sono quello che ti
adora e tu contro di me Che vuoi ora? che muoia per te?
Desposastesos señora Solo por de mi os quitar
Casareys y habreis pesar.
Pues que tan mal gualardon
A los mis serviçios distes.
Que pagueis lo que hezistes
Lo que no lleva Razon.
Vuestro bravo coraçon
ya esta en tiempo de amansar
Casareys y habreis pesar.
Signora
vi sposate Solo per liberarti di me
Ti sposerai e ti
pentirai
Poiché tanto cattiva ricompensa hai dato
ai miei servigi
Che paghi ciò che hai fatto ciò che
non ha alcuna ragione.
Il tuo cuore coraggioso è
ancora in tempo per quietarsi
Ti sposerai e ti pentirai
Ay de mi quen tierra
agena
me veo sin alegria
Quando me vere en la mia
Y no por estar ausente De mi tierra es el pesar
Mas por no poder estar Dondesta mi bien presente.
No ay consuelo suficiente
a mal que tal bien desvia
Quando me vere en la mia
Guai a me che in terra straniera mi vedo senza gioia
Quando
mi vedrò nella mia?
E non per essere lontano Dalla mia
terra è il peso,
ma per non poter essere Dov'è presente
il mio bene
Non ho abbastanza consolazione per un
male che tale bene allontana
Quando mi vedrò nella mia?
Serrana Donde dormistes Tan
mala noche me distes
A
ser sin vuestro marido
U
sola sin compañia.
fuera
la congoxa mia
no
tan grande como a sido.
No
por lo que haveys dormido
mas
por lo que no dormistes
Serrana dove hai dormito Mi hai dato una notte così
brutta
Stando senza tuo marito E sola senza compagnia
La mia angoscia non sarebbe
stata così grande come è stata.
Non per quello che hai dormito ma
per quello che non hai dormito.
Y dezid serranicas he
Deste
mal si morire
Porquel
Remedio y mi mal.
Nascen
de una causa tal.
que
me hazen Immortal
por
do morir no podre
Deste
mal si morire
Que
de ver la Serranica
Tan
gratiosa tan bonica
Mi
dolor me certifica
Que
jamas no sanare
Deste
mal si morire.
E
dite pastorelle, su,
se morirò di questo male
perché il rimedio e il mio male
nascono da una causa tale
da rendermi immortale,
per cui non potrò morire
se morirò di questo male
perché quando vedo la pastorella
così graziosa e così bella
il mio dolore mi assicura
che non guarirò mai
se morirò di questo male.
Vi los barcos madre
Vilos y no me valen.
Madre tres moçuelas
Non de aquesta villa.
En aguas corrientes
lavan sus camisas.
Sus camisas madre
Vilos y no me valen.
Ho visto le navi madre le
ho viste e non sono degne di me
Madre tre ragazze di
un’altra città
In acqua corrente lavano le loro
camicie.
Le loro camicie madre le ho viste e non sono
degne di me